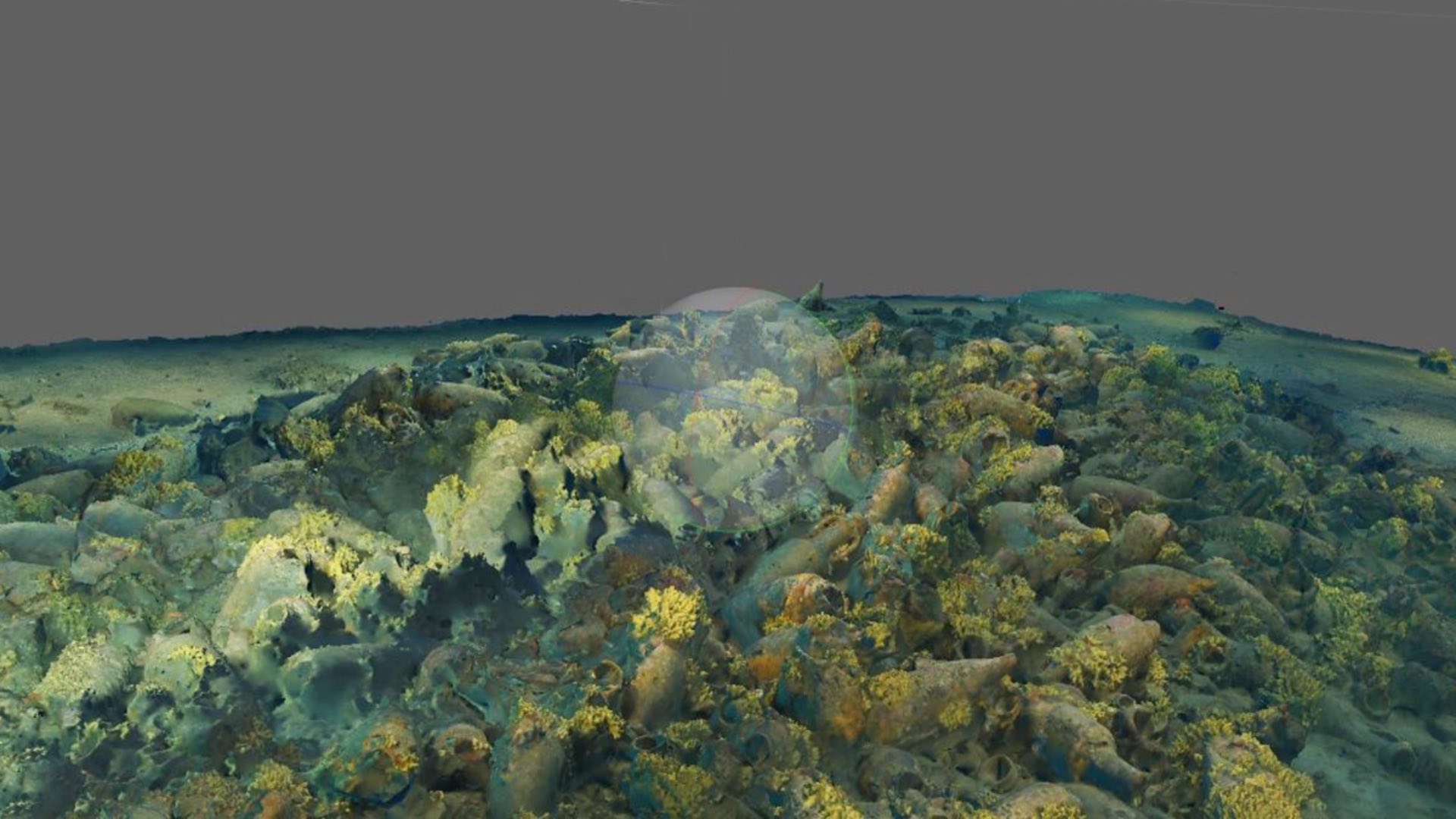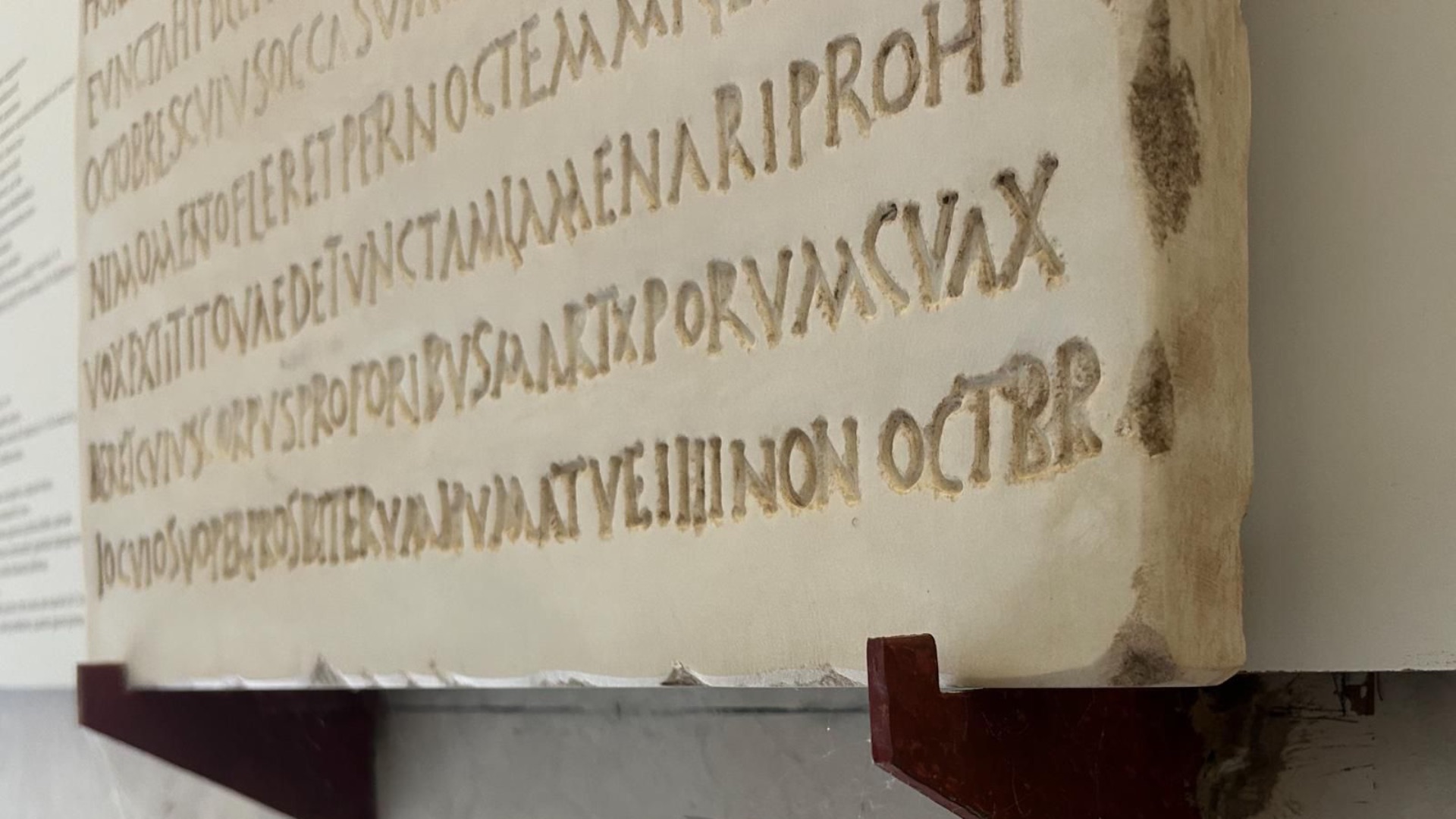◉ ITINERARI
Musica che si fa storia: viaggio nel tempo tra suoni e tradizioni
Alla scoperta del Museo Cultura e Musica popolare dei Peloritani di Gesso, a pochi chilometri da Messina, dove rivivono le sonorità arcaiche del paesaggio pastorale siciliano. Custodisce un patrimonio unico, fatto di zampogne, flauti e manufatti lignei, che rivela le radici millenarie di una tradizione ancora viva
di Giulio Giallombardo
14 Marzo 2025
Nell’antica Sicilia, terra di miti e leggende, la musica si intreccia con la storia, evocando un mondo perduto scandito da ritmi e melodie ancestrali. È la Sicilia pastorale cantata da Teocrito, archetipo poetico di una tradizione millenaria che ha attraversato i secoli, giungendo fino a noi. A custodire questo patrimonio è il Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di Gesso, uno dei 48 villaggi che circondano Messina. Da un quarto di secolo, questo museo racconta storie di pastori, suonatori e comunità rurali, offrendo una finestra privilegiata su un paesaggio sonoro che unisce Oriente e Occidente, tra le aspre cime dei Peloritani e le dolci colline dei Nebrodi.
Tra i sentieri battuti dai pastori e i boschi di castagni, aleggia il genius loci di una cultura agreste che affonda le sue radici nel neolitico. Mario Sarica, fondatore e curatore scientifico del museo, è il custode di questo mondo. Etnomusicologo formatosi alla scuola di Roberto Leydi e Febo Guizzi a Bologna, Sarica ha dedicato la sua vita alla riscoperta delle tradizioni musicali siciliane, conducendo ricerche sul campo sin dalla fine degli anni Settanta, soprattutto nell’area centro-orientale dell’isola. “Il museo è figlio di un lungo percorso che inizia nell’Ottocento con Giuseppe Pitrè – spiega Sarica -. Grazie alla resilienza della tradizione orale, abbiamo potuto mappare un patrimonio unico: strumenti musicali popolari, canti monodici e polivocali, e una pratica strumentale che si è conservata nei contesti agropastorali di lavoro e di festa. I pastori, i contadini, i cantori e i costruttori di strumenti ci hanno regalato testimonianze preziose, permettendoci di ricostruire un mondo che altrimenti sarebbe andato perduto”.
Nelle cinque sale del museo, flauti, clarinetti, oboi e zampogne dialogano con mandolini, violini, chitarre e tamburi, mentre strumenti ludici e rituali, come i fischietti di terracotta, raccontano il legame tra musica e infanzia. Ogni oggetto è un tassello di un codice di comunicazione orale che abbracciava ogni aspetto della vita, dal lavoro nei campi ai riti religiosi, dalle feste popolari alle serenate d’amore. “Oltre agli strumenti musicali – aggiunge Sarica – nel museo trovano spazio manufatti lignei pastorali, che ci aiutano a riscoprire le radici più antiche della cultura mediterranea. Sono testimonianze che dialogano con noi, suggerendo chiavi per rigenerare un legame virtuoso con il territorio e il suo patrimonio culturale. Ogni ciotola, ogni collare, ogni bastone intagliato racconta una storia di fatica, creatività e resistenza”.
La prima sala è dedicata alle feste patronali e agli ex voto, con oggetti di culto e strumenti di lavoro legati al ciclo del gesso. Qui, tra immagini sacre e suppellettili devozionali, si respira l’atmosfera delle processioni e delle feste in onore dei santi protettori. Nella seconda sala, il “grasso” del Carnevale si mescola al “magro” della Quaresima. Maschere arcaiche, come quella dell’Orso di Saponara, si alternano a figure penitenziali della Settimana Santa, come il Giudeo di San Fratello. Tra gli oggetti esposti spiccano trombe ricavate da conchiglie, corni bovini e una collezione di sonagliere e scacciapensieri, strumenti che univano funzione pratica e simbolica.
La terza sala è intitolata a Sostene Puglisi, pastore-suonatore e costruttore di strumenti, scomparso nel 2021. Qui si trovano testimonianze dell’homo faber del neolitico, con manufatti in legno di erica e gelso nero: collari, ciotole, cucchiai e barilotti. Tra gli strumenti spiccano gli arcaici aerofoni pastorali, come le zampogne a paro, tipiche dei Peloritani, e un antico tornio a pedale della famiglia Mento di Rometta, storici costruttori di zampogne. La quarta sala è un trionfo di violini, chitarre e mandolini, frutto della secolare tradizione liutaria catanese e messinese, esportata in Europa e America tra Ottocento e Novecento. Qui si trovano anche grandi tamburi a bandoliera, ancora oggi protagonisti delle processioni, e una collezione di fisarmoniche e organetti.
Completano il museo una sala multimediale, con postazioni per l’ascolto e la visione di materiali audiovisivi, una biblioteca specializzata in cultura popolare siciliana, un giardino con piante officinali e un mulino in pietra lavica. La sala di animazione musicale, utilizzata per eventi e concerti, ha ospitato negli anni musicisti, cantori e studiosi, diventando un punto di incontro per la comunità.
Il museo racconta anche storie di emigrazione, come quella degli ibbisoti (abitanti di Gesso), che dopo l’Unità d’Italia partirono per gli Stati Uniti, ricreando a Hammonton, nel New Jersey, un microcosmo di usi e costumi siciliani. È in quel piccolo centro all’altro capo del mondo che gli emigrati replicarono usi e costumi della società rurale siciliana, prima lavorando nei campi, poi diventando proprietari terrieri. Un microcosmo creato dal nulla studiato dall’antropologa Emily Fogg Mead. Dunque, il museo peloritano, grazie ad un percorso espositivo interdisciplinare, è in grado di interagire su più registri di comunicazione, da quello visivo al sonoro, integrando testi e video. “Un’immersione totale in un mondo apparentemente lontano e estraneo al contemporaneo – osserva Sarica – , eppure capace di offrire un’inaspettata esperienza multisensoriale unica, di forte impatto emozionale e di riconoscimento identitario. Una scelta non casuale, quella di affidarsi agli strumenti da suono e musicali della tradizione siciliana, per lasciarsi guidare alla riscoperta di un universo agro-pastorale perduto”.
Oggi l’eredità raccolta dal museo, la cui titolarità è stata assunta fin dalla sua prima apertura dall’associazione culturale Kiklos, viene portata avanti da alcuni giovani interpreti, anche se i contesti rurali originari sono ormai scomparsi. “Il nostro museo è un incubatore culturale – conclude Sarica – . Un luogo vivo che fa incontrare artigiani, musicisti e studiosi per fare ricerca e trasmettere saperi. Lavoriamo per aprire nuove strade, anche dialogando con culture diverse dalla nostra. La musica popolare siciliana, pur radicata nel passato, ha ancora molto da dire al presente”.